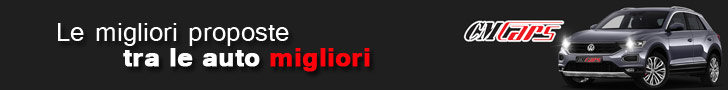Motori a benzina e diesel dopo il 2035: un possibile revival in un contesto di neutralità tecnologica e sostenibilità
Quando il futuro della mobilità si combina con strategie di innovazione e attese di ripensamenti normativi, emergono interrogativi complessi e non più facilmente prevedibili. La saga dei motori termici, in particolare quelli a benzina e diesel, sembra assumere un volto nuovo, sfidando le narrative che li volevano destinate all’estinzione entro il 2035. La tensione tra obiettivi di decarbonizzazione e la volontà di preservare determinate tecnologie si traduce in un dibattito estremamente articolato, che sta attraversando le soglie di decisioni politiche e strategie industriali.*
Il 2035 rappresenta un confine simbolico e sostanziale per la trasformazione del settore automobilistico in Europa, dato che le normative comunitarie puntano all’eliminazione progressiva delle vetture con motri a combustione interna all’interno del mercato di massa. Concetti come “zero emissioni” e “comunità climaticamente neutre” sono al centro di questa strategia, che mira a ridurre drasticamente le emissioni di gas serra, in particolare di anidride carbonica, con l’obiettivo di contenere l’aumento delle temperature globali e di favorire una transizione energetica che in tanti avevano considerato irrevocabile. Tuttavia, la narrazione sembra essere più sfumata di quanto filtrato dai titoli mediatici e dalle dichiarazioni di principio.
Su questa linea si inserisce la recente indiscrezione pubblicata dalla rivista tedesca Der Spiegel, che segnala un possibile ripensamento della stessa Unione Europea nel senso di preservare i motori a combustione tramite l’introduzione di soluzioni tecniche innovative, come i powertrain plug-in. Questo tipo di propulsore combina un motore termico a combustione interna con un sistema di accumulo di energia elettrica, consentendo di limitare le emissioni grazie alla possibilità di funzionare in modalità puramente elettrica per brevi tratti, riducendo considerevolmente i consumi e l’impatto ambientale. La prospettiva di definire alcune di queste motorizzazioni come tecnologie “a zero emissioni” a pieno titolo, almeno in determinate condizioni di utilizzo, viene considerata come un possibile elemento di svolta.
Nel documento recentemente pubblicato dalla Commissione Europea, questa volontà di mantenere un approccio neutrale dal punto di vista tecnologico emerge in modo autorevole: si parla di una “neutralità tecnologica” come cardine della strategia di decarbonizzazione, con una particolare attenzione rivolta anche ai carburanti sintetici, gli e-fuels. La loro possibile inclusione nel regolamento non sarebbe soltanto un passo indietro rispetto alla linea esclusivamente elettrica, ma un tentativo di riconoscere la validità di sistemi di propulsione che, pur non essendo completamente a zero emissioni, potrebbero contribuire a una transizione più graduale e meno traumatica. Questa eventualità apre le porte alla permanenza di motorizzazioni convenzionali, soprattutto in alcune fasce di mercato o zone geografiche più difficili da elettrificare.
E come sottolineato dal noto lobbista di Mercedes, Eckart von Klaeden, la volontà di lasciar parlare il mercato e di favorire una libertà regolamentare più ampia rappresenta un elemento che potrebbe sovvertire le attese precedenti. La sua posizione si inserisce in una filiera di intenti che vedono la regolamentazione non più come un vincolo rigido e definitivo, ma come un quadro di riferimento flessibile in grado di adattarsi alle variazioni di rilievo strategico. La regolamentazione dei veicoli ibridi plug-in, chiamati anche PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle), è già affinata: dal 1° gennaio 2025 si sono definiti nuovi standard Euro 6e-bis, che impongono test più rigorosi per omologare i veicoli e dichiarare consumo ed emissioni più aderenti alla realtà. Questa scelta appare come un tentativo di colmare il divario tra dati ufficiali e emissioni effettive, spesso molto più elevate di quanto comunicato in origine.
Il ruolo dei powertrain PHEV nel prossimo futuro si configura come un esempio emblematico di questa tendenza: sebbene siano spesso considerati una soluzione temporanea o transitoria, il loro sviluppo e la regolamentazione più severa ne stanno confermando il valore come “ponte” verso un mercato più pulito e sostenibile. Dal punto di vista pratico, significherà un’attenzione ancora più acuta alle performace ambientali e alle emissioni reali, spingendo le aziende a investire su sistemi di controllo più sofisticati e su tecnologie di combustione meno inquinanti, come lo sviluppo di motori a benzina di ultima generazione e di combustibili alternativi.
In questa cornice si inserisce anche la questione più ampia del ruolo delle tecnologie ibride e della loro eventuale sopravvivenza oltre il 2035. La discussione tra istituzioni, aziende e associazioni di categoria si sta intensificando, con segnali che indicano una volontà di mantenere aperti tutti gli scenari possibili. La decisione di prorogare la vita utile dei motori a combustione, se così si potrebbe definire, potrebbe consentire di preservare anche l’importanza economica e industriale di settori che, altrimenti, rischierebbero di essere marginalizzati troppo in fretta.
Il confronto tra la Commissione Europea e i produttori di automobili non si limiterà a una semplice negoziazione di limiti e standard, ma darà vita a un vero e proprio scambio di visioni, interessi e possibilità di mitigare eventuali contraccolpi sociali ed economici di una transizione troppo accelerata. È, infatti, evidente che una fetta consistente di mercato domicilia nel settore delle vetture ibride e negli alimentati a carburanti sintetici, i quali rappresentano delle alternative di attuazione concreta alla totale electricizzazione che molti paesi e città stanno già iniziando a considerare come obiettivo più che raggiungibile.
Le cifre supportano l’argomentazione di un possibile revival dei motori tradizionali anche dopo il 2035. Secondo uno studio di Transport & Environment, un’organizzazione indipendente di analisi del settore mobilità, in alcuni Stati membri dell’UE la penetrazione di veicoli elettrici, benché in rapida crescita, non ha ancora raggiunto la saturazione e, in molte aree rurali o periferiche, pepite di motori a combustione sono ancora strategicamente fondamentali. La stessa Organizzazione Internazionale dei Automobilisti ha osservato come le infrastrutture di ricarica, spesso più lente e meno capillari in queste zone, rappresentino un limite rilevante al pieno passaggio alle fonti di energia alternative.
D’altra parte, alcune stime indicano che il settore dei carburanti sintetici potrebbe generare un volume di mercato compreso tra 50 e 100 miliardi di euro entro il 2040, un dato che mobilita interessi potenti a livello politico ed economico. Gli sforzi volti a coltivare questa possibilità non sono semplicemente un’eccezione, ma costituiscono l’orientamento di diverse aziende e governi che vedono nel potere delle tecnologie ibride e dei combustibili sintetici una strada più compatibile con scenari di de-carbonizzazione graduale e con la crisi delle risorse.
Da ultimo, anche i recenti test di omologazione e le nuove normative su consumo ed emissioni mettono in evidenza che, mentre ci si avvicina al 2035, il settore automotive si trova di fronte a una fase di profonda trasformazione non ancora definita entirely. La partita tra regolamentazione e innovazione tecnica si sta giocando a livelli che vanno oltre le semplici politiche ambientali, coinvolgendo interessi industriali, tecnologici e sociali, richiedendo una capacità di adattamento rapida ma ponderata.
Le promesse di un futuro senza motori a benzina e diesel sono state spesso considerate come un obiettivo assoluto, un punto di non ritorno. La realtà sembra invece indicare che, piuttosto, si potrebbe essere di fronte a un’area di transition dove diverse soluzioni coesisteranno, sostenute da un quadro normativo che potrebbe risultare più elastico di quanto annunciato nelle linee guida principali. Una sfida che comprende non solo strumenti tecnologici, ma anche strategie di mercato e scenari di sviluppo che devono coniugare sostenibilità e continuità industriale.
Questo scenario tutt’altro che lineare sottolinea come le decisioni, la politica e l’innovazione tecnologica siano profondamente intrecciate. La volontà di mantenere un regime di “neutralità tecnologica” potrebbe risultare decisiva nel decennio che ci attende, consentendo ai motori a combustione di trovare ancora uno spazio nel panorama della mobilità del futuro. Un equilibrio difficile da raggiungere, ma strategicamente cruciale per garantire che la transizione verso un mondo sostenibile possa passare attraverso molte più sfumature di quanto si fosse immaginato solo pochi anni fa.
Fonti affidabili e dati statistici
- Rapporti della Commissione Europea sulla strategia di neutralità tecnologica e sui limiti delle emissioni.
- Studi di Transport & Environment sulla penetrazione dei veicoli elettrici e delle tecnologie ibride nell’UE.
- Dati dell’Organizzazione Internazionale dei Automobilisti sulle infrastrutture di ricarica e sulla distribuzione geografica delle motorizzazioni.
- Analisi di mercato del settore carburanti sintetici, stimata tra 50 e 100 miliardi di euro entro il 2040.
- Rapporti di organismi indipendenti sull’impatto delle nuove normative Euro 6e-bis e sulla loro applicazione ai veicoli plug-in hybrid.
Nel dibattito politico, l’atteggiamento verso i motori termici rimane oggetto di negoziazioni che rivedono la loro destinazione, inserendo nuove variabili che potrebbero comunque rivoluzionare il panorama di settore. Di questa complessità, chi scrive si limita a sottolineare come il ruolo delle tecnologie ibride e dei carburanti alternativi possa figurare come elemento di continuità e di innovazione, sintetizzando in modo simbolico le sfide di una transizione che si preannuncia tutt’altro che lineare e definitiva.